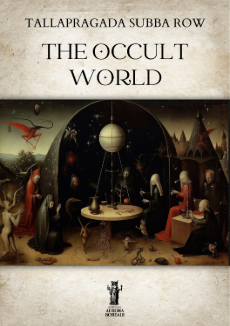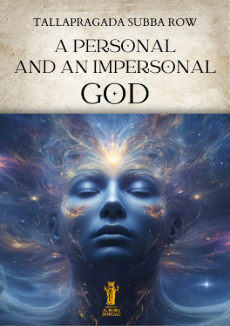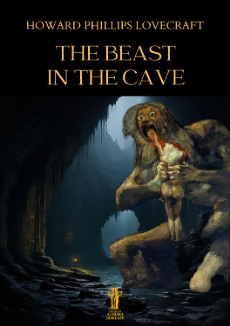LA LUNGA STRADA VERSO I PRATI DI PERSEFONE
di Nicola Bizzi
Fin dagli albori della storia e della civiltà, l’essere umano ha avuto e trasmesso alla propria comunità e alla propria progenie la consapevolezza di essere una creatura pensante animata da una scintilla divina, di essere in sostanza un frammento di Eternità. Ha avuto il sentore, oserei dire la certezza, di non essere limitato ad una mera esistenza fisica destinata a terminare con il decadimento e la morte del suo “involucro”, ma di essere bensì destinato in qualche modo a ricongiungersi con quelle stesse Forze creatrici che regolano l’esistenza, l’energia del cosmo e le dinamiche potenti e immutabili della Natura. E, di conseguenza – come ci attestano innumerevoli reperti archeologici e la stessa nascita del sentimento religioso e della Filosofia – ha sempre posto in un ruolo di primo piano il proprio rapporto con il Trascendente, ponendosi delle fatidiche domande: Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo?
In particolare è sempre stato l’ultimo di questi tre interrogativi, ovvero dove siamo destinati ad andare, non solo metaforicamente e materialmente sulla via tracciata dal destino, ma anche e soprattutto dopo la fine della nostra esistenza terrena, a stimolare nell’umanità l’incessante necessità di risposte. Risposte che l’uomo, fin dalla Preistoria, si è in buona parte dato con la nascita e lo sviluppo del pensiero religioso e, successivamente, con la nascita della Filosofia.
Il termine Filosofia (Φιλοσοφία), che in Greco antico si compone da φιλεῖν (phileîn), “amare”, e σοφία (sophía), “sapienza”, significa letteralmente “amore per la sapienza”.
I moderni dizionari e le enciclopedie definiscono concordemente la Filosofia una disciplina e al contempo un campo di studi che si pone domande e riflessioni sul mondo e sull’uomo, indaga sul senso dell’essere e dell’esistenza umana, tenta di definire la natura e si occupa dei limiti e delle possibilità della conoscenza. Ma prima ancora che indagine speculativa, la Filosofia è stata una disciplina che seppe assumere anche i caratteri della conduzione di un determinato “modo di vita”, ad esempio nell’applicazione concreta dei principi desunti attraverso la riflessione e il pensiero, e in questa forma la si fa sorgere, ne si collocano le origini ed i fondamenti, proprio nell’antica Grecia. Ma a rendere complessa una definizione univoca della Filosofia concorse il dissenso (ancora oggi tutt’altro che risolto) tra i suoi protagonisti ed artefici (i Filosofi) sull’oggetto stesso di tale disciplina. Un falso problema questo, perché, se andiamo all’origine, i più antichi Filosofi non ponevano una netta linea di demarcazione fra Philo-Sophia e Sapere Sacro. E, come giustamente sottolineava Victor Magnien, «la Filosofia greca deriva dai Misteri, almeno secondo l’opinione degli stessi Greci».
La semplice traduzione dal termine greco (“amore per la sapienza”) non sarebbe certo di per sé sufficiente a rendere l’idea di cosa sia stata e di come venisse intesa e percepita la Filosofia nell’antico mondo ellenico anche perché il significato che il termine poteva rivestire in un contesto culturale, quello dell’antichità classica, in cui l’uomo era più vicino agli Dei e gli Dei erano più vicini all’uomo, si distanzia enormemente dai significati e dalle interpretazioni che della Filosofia sono stati dati nelle epoche successive, dal Medio Evo all’Età Moderna, caratterizzate da ambiti sia socio-economici che cultural-religiosi completamente diversi.
Finché non ci spogliamo della cappa di modernità che ci avvolge, e soprattutto dai plurisecolari condizionamenti che essa ha necessariamente comportato, influenzando il nostro modo di vivere, percepire e vedere noi stessi e la realtà che ci circonda, non riusciremo a comprendere pienamente le opere che ci hanno lasciato indiscussi Maestri del pensiero quali Platone, Plotino, Porfirio, Proclo e molti altri ancora.
Ma la Filosofia greca, sia che la intendiamo come Sapere Sacro e amore per la Divina Sapienza, che come scuola di vita e palestra di riflessione, meditazione, introspezione ed elevazione, a differenza di specie ormai estinte come l’Homo Erectus o l’Homo Neanderthalensis, è tutt’altro che appartenente al passato. Essa è tutt’oggi viva e pulsante e, nonostante i pesanti ed innegabili condizionamenti sociali dovuti a duemila anni di Cristianesimo che ne hanno alterato parte della natura e del messaggio intrinseco, continua a costituire la base stessa della nostra forma mentis e del nostro bagaglio culturale.
Giorgio Giacometti ha affermato in un suo saggio che «in ciò siamo soccorsi dagli stessi testi antichi che per aiutare la concentrazione passano di punto di vista in punto di vista (donde l’apparenza in essi della contraddizione e dell’eclettismo)» e che «a tale soccorso dobbiamo aggiungere quello di testi e maestri moderni che ci forniscano la chiave di lettura e di meditazione di questi scritti». Ma è semmai, dal mio punto di vista, l’esatto contrario. Nessun autore, nessun filologo o nessun sedicente “filosofo” moderno potrà mai fornirci le corrette chiavi di lettura della Philo-Sophia antica, e in particolare di quella platonica e neoplatonica. Tali chiavi di lettura, a meno che non ci si accontenti degli aspetti più esteriori (dell’involucro, potremmo dire), le si raggiungono in soli due modi: attraverso un’Iniziazione misterica e il relativo processo graduale di elevazione/apprendimento sotto l’attenta guida di un Mystagogo, o, in maniera profana (e quindi necessariamente incompleta o parziale), attraverso una prolungata e faticosa attenta lettura dei testi dei Maestri del passato, accompagnata da una propedeutica ma indispensabile spoliazione catartica di ogni pregiudizio preconcetto dettato dai condizionamenti socio-culturali e religiosi del mondo contemporaneo.
Sempre Giorgio Giacometti, in Meditare Plotino, rifacendosi agli studi del filosofo e teologo francese Pierre Hadot – e in particolare al saggio di quest’ultimo intitolato Esercizi spirituali e Filosofia antica – evidenzia molto il ruolo della Filosofia come ασκησις, cioè come esercizio o meditazione. Ci ricorda infatti come Hadot, muovendosi dalla considerazione di quanto la Filosofia antica interpretasse sé stessa come esercizio, sia arrivato a comprendere quanto la Tradizione antica continui a vivere in noi, per lo più inconsapevolmente (come potenza o latenza) e quanto essa possa parlare al disagio dell’uomo contemporaneo sicuramente più e meglio di altre Tradizioni, ivi comprese quella Cristiana e quelle orientali.
Sotto questo profilo, sulla base degli studi di Hadot, la Filosofia si presenta innanzitutto come arte del vivere, o come arte di vita e di morte, o, se vogliamo essere ancora più precisi, coma arte del saper vivere e del saper morire. E non è certo una casualità il fatto una simile definizione sia per eccellenza la medesima della Tradizione misterica ed iniziatica, e di quella eleusina in particolare.
Già nel 1928 il noto teosofo ed esoterista olandese Johannes Jacobus Van der Leeuw, nel suo celebre saggio The Conquest of illusion, ci ricordava come la Filosofia debba essere intesa soprattutto come ricerca della vita e che essa è più che amore per la saggezza, a meno che non intendiamo per saggezza qualcosa di diverso dal sapere. Secondo Van der Leeuw, la stessa saggezza è conoscenza ed esperienza, e perciò è vita. E la ricerca della saggezza deve quindi essere intesa anche come ricerca della vita. Ma la vera Filosofia non deve limitarsi ad essere una mera soluzione intellettuale dei problemi. Nelle parole di Platone la Filosofia nasce dalla meraviglia, ed il vero Filosofo è colui che continua a meravigliarsi della vita, che non cessa mai di farlo, non colui che è certo di aver risolto ciò che sta al di là di ogni soluzione. È profondamente vero, quindi, come ci insegna Van der Leeuw, che finché non siamo in grado di vedere le meraviglie della vita intorno a noi, a meno di non vederci come avvolti in un mistero che sfida la nostra audace esplorazione, non siamo ancora sull’autentico sentiero della Filosofia.
Come ci spiega sempre Van der Leeuw, l’uomo non risvegliato conosce solo i fatti, non conosce misteri; per lui le cose si spiegano da sole; il mondo esiste, cosa altro c’è da sapere? Ma questo è un modo di vedere animale; per una mente bovina il pascolo può essere buono o cattivo, e non c’è bisogno di spiegazioni. E quindi l’uomo non risvegliato si accontenta dei fatti dell’esistenza: l’ambiente che lo circonda, il cibo, il lavoro, la famiglia e gli amici sono altrettanti “fatti” che lo circondano, fatti piacevoli o spiacevoli, ma che non hanno per lui mai apparente bisogno di essere spiegati. Parlargli di un mistero celato nella sua vita e nel suo mondo potrebbe sembrare cosa vana e non avrebbe alcun senso; egli vive, e il semplice fatto di vivere gli basta. La morte e la vita stesse possono per un momento infondergli un senso di ansia o di gioia, ma anche in tale caso non risvegliano in lui alcuna curiosità: sono in fondo per lui cose familiari e abituali. Ed è proprio questa apparente familiarità alla vita che cela il suo mistero alla mente animale.
L’uomo non risvegliato così mirabilmente descrittoci da Van der Leeuw rappresenta purtroppo oggi, a differenza che nell’antichità – quando, come abbiamo detto, in un reale scambio e connubio l’uomo era più vicino agli Dei e gli Dei più vicini all’uomo e assai maggiore era il livello di consapevolezza – più una regola che l’eccezione. Buona parte dell’umanità è oggi assimilabile ai protagonisti dell’allegoria della caverna spiegataci esemplarmente da Platone nella Repubblica. E la Filosofia, l’autentica Philo-Sophia, può, oggi più che mai, – a differenza delle imperanti religioni monoteistiche fondate sul dogmatismo e sulla logica “del bastone e della carota” – rappresentare per tanti di questi uomini un raggio di luce capace di squarciare le tenebre in cui sono avvolti e contribuire così al loro risveglio (per quanto traumatico esso possa essere) e al loro cammino sul sentiero della Consapevolezza.
Quanto appena riportato non può non richiamarmi alla mente un paragone molto calzante ed esplicativo riportato da Corrado Malanga nel suo illuminante saggio Genesi. Mi sto riferendo alla metafora del cavallo/cavaliere, secondo la quale il cavaliere, nella sua dualità, rappresenta il nostro spirito, e il cavallo il nostro corpo fisico. Tale metafora ci insegna che ciascuno di noi nella vita è contemporaneamente cavallo e cavaliere, ma il cavaliere deve sempre cercare di dominare e controllare il proprio cavallo, conoscere il suo stato di salute, i suoi turbamenti e le sue debolezze. Nel nostro pellegrinaggio terreno – scrive Malanga – spesso accentuiamo a tal punto il contrasto della dualità del cavaliere (maschile, forza, ragione, lato sinistro del cervello, contro femminile, dolcezza, passione, lato destro del cervello) perdendo di vista il vero obiettivo del cammino intrapreso: godere del dono della vita.
L’esercizio spirituale della Filosofia, nelle interpretazioni di Pierre Hadot, non è inteso solo come mezzo che ha per fine il vivere bene, ma esso stesso incarnerebbe il modo migliore di vivere. La Filosofia, quindi, come ci insegna Aristotele nella Metafisica, può essere intesa come fine a sé stessa purché con ciò non si intenda assimilarla ad un ozioso gioco speculativo, ma la si prenda sul serio come esercizio che impegna e richiede tutte le energie della vita; il che, come ci ricorda Giacometti, può anche essere espresso con l’affermazione che la vita stessa non ha senso se non come esercizio di morte, ossia come accettazione e disponibilità al trapasso, conoscendo sé stessi nel proprio autentico sé, al di là dell’io=corpo (o del “cavallo” secondo la metafora malanghiana), dell’individuo, quell’io che non altro rappresenta, in fondo, che l’ultima delle passioni o illusioni.
Un insegnamento, anche questo, che rientra a pieno titolo fra quelli della più autentica Tradizione Misterica. Come giustamente osservava Victor Magnien, il Socrate che Platone fa parlare nell’Apologia professa certo le idee e le dottrine insegnate nei Misteri quando afferma: «Se un uomo, liberato da coloro che qui pretendono di essere giudici, giunge presso Hades e vi trova i veri giudici che si dice giudichino laggiù, Minosse, Radamante e Eaco e tutti i Semi-Dei di cui fu detto che condussero una vita giusta, compie forse un cambiamento di cui si debba rammaricare? Dimorare assieme ad Orfeo, Museo, Esiodo e Omero non è una sorte da tenersi in gran conto?».
Come sottolineava Giovanni Pugliese Carratelli, dell’immagine, così persistente nella letteratura greca dall’età arcaica alla classica, della vita umana come un tessuto di sofferenze hanno cercato di dare una giustificazione i primi teologi e i primi filosofi (due categorie che, come spiego spesso nei miei saggi, nel mondo antico erano spesso coincidenti e compenetranti). E, con la nascita e lo sviluppo dei culti misterici – che, attraverso un percorso iniziatico e di elevazione e un duro lavoro di lotta contro sé stessi, offrivano e garantivano ai propri adepti non solo le risposte ai grandi interrogativi che già abbiamo menzionato, ma anche la salvifica certezza di una vita eterna – si è fatta strada nei popoli antichi la piena consapevolezza di una sopravvivenza oltre questa vita fisica. La piena consapevolezza del fatto che esista una piena correlazione fra morte e iniziazione, e sul fatto che il Filosofo, come l’iniziando a Eleusi, “intende a morire”, e intende a farlo, come ricordava Marco Tullio Cicerone (non a caso un grande iniziato eleusino), «cum laetitia vivendi rationem accepimus, sed etiam cum spe meliore moriendi».
Ma gli insegnamenti misterici non si limitavano a far affrontare agli adepti la morte con letizia e a dare loro la speranza di una vita eterna. Mettevano gli iniziati anche in guardia dai terribili pericoli che avrebbero potuto affrontare una volta varcata la fatidica soglia, conferendo loro delle vere e proprie “istruzioni” per non cadere nelle trappole di forze oscure avverse all’umanità – forze arcontiche e vampiriche che si nutrono della nostra stessa energia animica – e per giungere indenni ai Campi Elisi, ai Prati di Persefone.
«Troverai a destra delle case di Ade una fonte, e accanto ad essa un bianco cipresso: a questa fonte non avvicinarti neppure. Più oltre troverai la fredda acqua che scorre dal lago di Mnemosyne. Vi stanno innanzi i custodi, ed essi ti chiederanno a qual fine sei giunto fin lì. A loro tu esponi tutta la verità; dì: “Sono figlio della Terra e del Cielo stellato; Astérios è il mio nome. Sono arso di sete: datemi da bere dalla fonte”». Così recita il testo di una delle tante laminette d’oro (nello specifico quella rinvenuta a Pharsalos, in Tessaglia), impropriamente definite dagli archeologi “orfiche”, che venivano deposte nei sepolcri degli iniziati eleusini e che contenevano le istruzioni per intraprendere correttamente il viaggio ultramondano.
Nel contesto degli antichi Misteri, l’Epopteia rappresentava l’esperienza contemplativa culminante, ed è proprio per questo che uno dei principali significati del termine Ἐπόπτης è “Contemplare” o “Contemplare del Tempio”, cioè colui a cui è consentito contemplare gli Dei da vicino. Ma soprattutto, come evidenziò nel 1841 Jean Marie Ragon, «colui che vede le cose tali e quali sono, senza veli».
Se la Mysta comporta per l’iniziando una morte rituale simbolica e “di concetto”, con l’Epoteia l’Iniziato vive l’esperienza di una morte rituale vera e propria. O, quella che in termini moderni, potremmo definire un’esperienza di pre-morte. Chi scrive lo sa con cognizione di causa, perché – ve lo posso assicurare – ci sono passato in prima persona.
Un discusso frammento oggi attribuito ufficialmente a Plutarco di Cheronea, ma che, prima dell’attribuzione voluta e di fatto imposta da Francis Henry Sandbach, molti filologi classici ritenevano (secondo me a ragione) di Plutarco di Atene, risulta fondamentale per comprendere la natura dell’esperienza epoptica: «L’anima al momento della morte fa un’esperienza analoga a quella provata da coloro che si sottopongono all’iniziazione ai Grandi Misteri. Perciò anche il verbo teleutàn (morire, n.d.A.), come anche l’azione che esso esprime, sono simili a teléisthai (essere iniziato, n.d.A.). Dapprima si erra faticosamente, smarriti, correndo timorosi attraverso le tenebre senza raggiungere alcuna meta; poi, prima della fine, si è pervasi da ogni genere di terrore, spavento, tremore, sudore e angoscia. Ma poi una meravigliosa luce ci viene incontro e si è accolti da luoghi puri e da prati, dove risuonano voci e si vedono danze, dove si odono solenni canti ieratici e si hanno divine apparizioni. Tra questi suoni e queste visioni, ormai perfetti e pienamente iniziati, si diviene liberi e si procede senza vincoli, con ghirlande di fiori sul capo, celebrando i Sacri Riti insieme agli uomini santi e puri. Si osserva allora la massa degli uomini che vivono qui sulla terra, i non iniziati e i non purificati, schiacciarsi e spingersi nel fango della palude e nelle tenebre, attanagliati dalla paura per i mali della morte a causa della mancanza di fiducia nei beni dell’Aldilà».
Quest’opera di Fiorella Rustici che vi apprestate a leggere è un vero e proprio romanzo iniziatico, e come tale non è indubbiamente un libro per tutti. Si tratta infatti di un testo capace di trascinare chi vi si immerge nelle complesse e sconcertanti dinamiche del post-mortem, alla ricerca del più profondo significato dell’esistenza umana. Un libro capace di fornire delle risposte che non tutti possono essere in grado di recepire e di affrontare, soprattutto se non dispongono di un adeguato livello di Consapevolezza. Ma, al contempo, si tratta di un libro ricchissimo di verità (anche terribili) e di infiniti spunti di riflessione, sicuramente per certi versi sconvolgente, che di sicuro non lascerà indifferenti i lettori. E l’Anima risvegliò il suo Dio è un libro che molto probabilmente – oserei dire inevitabilmente – scardinerà in chi lo legge molte false certezze e risposte accomodanti, contribuendo a far aprire gli occhi sul grande mistero della Vita.